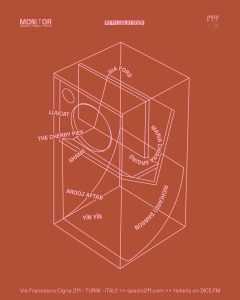“Open”: ovvero Max Trani, i Dog Byron, e un viaggio lungo 11 anni
“Se non gli stai dietro, a questi dell’organizzazione, finisce che per colpa della loro disorganizzazione si crei casino coi ragazzi”, dice – tra sorrisi ed abbracci dati e contraccambiati – Max Trani, una vita da musicista e ormai professionista del rock e della musica in genere.
Ed in effetti, non si fatica un granché a vederlo adeguatamente sicuro del suo ruolo di tour manager, tenendo sotto controllo il gruppo di turno – uno dei tanti che segue nel lunga scalata verso il cielo, per diventare ‘grandi’ nel rock – dato che è lì per seguirli in una data del loro tour, a gestire ogni imprevisto che in un contesto così affollato di band (e spettatori) puntualmente capita. Per Max Trani in arte Dog Byron, d’altra parte, non è di certo una situazione nuova, affatto: 25 anni di musica live, di concerti, di tour europei al fianco di band internazionali, vissuta sul palco stando dietro ad un microfono, e con una chitarra in mano a fargli da solo scudo.
Ed infatti, lui e i suoi Dog Byron li ho conosciuti (ed iniziati ad apprezzare) anni fa, proprio andando ad ascoltare i Turin Brakes, una di quelle band che girano il mondo riempiendo palazzetti e partecipando a festival musicali da presenze a cinque cifre, gruppi a cui è comunque complesso arrivare a fare da apripista e appoggio: e non solo dal punto di vista dell’essere scelti. Perché se non sei più che convinto delle tue decisioni musicali e dei tuoi mezzi artistici, se non hai limato le tue referenze e saputo costruire le tue preferenze e inclinazioni armoniche, e i tuoi gusti stilistici, se non hai fatto tuoi quegli stilemi e virtuosismi che in altri potrebbero solo sembrare vezzo, certi palchi possono diventare il luogo peggiore dove dimorare, dei veri e propri incubi anche solo per un set di mezzora.
È che la musica va vissuta, prima che suonata: se la fai tua, se la rendi materia dotata di un’anima e di una fisionomia il più simile a ciò che sei tu, non c’è più nulla da temere. Non da ‘Lei’, né tantomeno dalla reazione di chi la ascolterà e la farà diventare un pezzo della propria pelle, anche se fosse solo per il tempo di quei 1800 secondi circa che si susseguono ritmati e armoniosi tra un pezzo e l’altro.
Non ti preoccuperai nemmeno se dalle sonorità ruvide e ‘sporche’ – così vicine alla musica grunge e al post punk – di “Dog Byron”, quel primo album ormai distante più di dieci anni da qui, avrai voglia di passare a qualcosa di più intimo e ragionato, con un sound equilibrato e ‘pettinato’, variamente vestito in abiti a volte comodamente elettronici, laddove ci vuole. Perché è questione di crescita, e il pubblico è in effetti cresciuto con te. Quel pubblico che “in questi anni abbiamo sottovalutato perché riteniamo di appartenere a una nicchia e veri amanti della musica che sentono di avere una marcia in più. Ma anche il pubblico meno di nicchia può essere colto e notare anche dettagli di produzione: la voce, il basso… non si possono sottovalutare queste cose né ragionare con preconcetti sul pubblico.”
Le persone invece ascoltano. E apprezzano, spesso, la sincerità.
“Certo ci sono varie fasce: chi considera la musica come intrattenimento, chi la ascolta per ascoltarla ed è pronto a cogliere le sfumature. Essere un piccolo gruppo, certo, ti rende comunque più libero da vincoli e obblighi, anche rispetto a una fan base che ha delle aspettative. La nostra è composta da un pubblico molto colto e anche quando abbiamo avuto paura di risultare troppo rock, abbiamo provato a trattenerci: ma ci siamo resi conto che il nostro pubblico europeo è trasversale e molto colto, pronto ad ascoltare.”
Non avere pregiudizi e andare oltre le proprie rigidità: un concetto a cui non è facile dare spazio, precetto parecchio complicato da seguire. Non uscire dalle zone di confort presuppone meno rischi e molta meno fatica, ma di certo anche meno sorprese positive e parecchie meno soddisfazioni, alcune delle quali debitrici di un lavoro sui propri mezzi, che è sempre crescita: in certi casi, anche per effetto degli anni che passano e della materia che cresce, e si affina e si conforma insieme a te. Come ad esempio, la voce, diventata a suo modo più pulita e versatile con gli anni: “Anche nella voce c’è stata una evoluzione in parte naturale e in parte ricercata: è uno strumento delicato, e molto legato alla scrittura: molte registrazioni sono state fatte quasi sussurrando perché mi veniva naturale così. Non voglio rinnegare il passato ma di certo alcuni suoni strillati sono stati un tempo uno scudo. Ora mi sento più libero di raccontare in modo più vero. Questa è una evoluzione di cui sono contento, non solo dal punto di vista artistico ma anche personale.”
Il bello del lasciarsi evolvere, è che poi ti guardi indietro e arrivi a trovare le tracce di quel ‘te stesso’ che sei diventato senza alcuna malinconia, o nostalgica voglia di un ritorno al passato. Siamo esseri che camminano nello spazio e nel tempo: e anche i tempi, quelli musicali, camminano con noi ad un passo armonico che è quasi una sorta di jam session.
“Per me il passato dei Dog Byron ha perso valore, cioè è difficile che ci ripensi con malinconia. Quello che abbiamo fatto appartiene a un momento preciso, però il modo di farlo è sempre stato molto meticoloso, quasi paranoico su certe cose, molto attento a certi particolari e questo mi rende contento, anche dopo dieci anni. Ci sono però delle cose che non mi piacciono ora ma che allora erano inevitabili. Per questo ripeto che dal punto di vista della voce vedo una evoluzione, una crescita e sviluppo naturale. Non voglio prendermi dei meriti per una cosa che è venuta spontaneamente. All’epoca era così e non si poteva fare altrimenti: ad esempio la pronuncia è stata fonte di imbarazzo un tempo, poi ci siamo confrontati con l’estero, e siamo cresciuti pure in questo”.
D’altra parte, anche i Radiohead (e quindi, per estensione, i The Smile, NDR) non sarebbero quello che sono oggi se non fossero passati attraverso Pablo Honey e The Bends, per poi uscire dalla propria agiata e rispettabilissima zona di confort e approdare a Ok Computer: “Loro sono avanguardia totale, imprevedibili: quando ascolti le loro nuove produzioni sai sempre che sono loro ma allo stesso tempo sei pronto ad ascoltare cose nuove e nella maggior parte dei casi stupiscono”.
Mi viene semplice ritrovarmi con Max, anche su parecchi aspetti che – nonostante partano dalla musica – hanno una valenza notevole pure nel modo di approcciarsi alla vita. E’ una persona aperta e solare, un rocker tranquillo con una evidente capacità di ascolto e di esplorazione, capace davvero di partire da un continente in tempesta per approdare sulle sponde di un altro in bonaccia. Ascoltare “Open”, il suo secondo album, rende questa sensazione di viaggio come se fosse visione di un tragitto ormai compiuto, del quale è possibile pure scorgere il solco che – navigando a pelo d’acqua – si è lasciato dietro. Così che l’acustica “Rock ‘n’ Roll Show” è un dolce mollare gli ormeggi, un ‘alla via così’ che si distende placido “under a burning sun” dalla voce di un nostromo simile alla “moon behind the blue trees” in un sogno. Un sogno che si fa nenia placida, dal cullare di rollii e beccheggi, sotto le “7 stars” del secondo pezzo, e lo scivolare della carena è una carezza, simile a quelle delle tue dita sulla pelle quando qualcuno di amato dorme al tuo fianco.
È viaggio e oceano (Ocean of my mind) anche il ricordo di un’ultima frase – “The end claim” – quasi rimasta in punta di gola, strozzata: di quelle che ti senti risuonare come fantasmi, quasi bruma sull’acqua a metà del tuo viaggio. Un viaggio notturno, ma mai cupo: forse solo crepuscolare, come certe poesie che aprono mondi e che ascoltare quasi pare come volare via, in cerca di quella felicità (“I’m just looking for happiness / and happiness is dancing here / I’m under a spell?”) quasi a portata di mano. D’altra parte, è proprio nei viaggi che i desideri si manifestano più chiari, e vivi: ci si lascia trasportare dalle distanze che volano e navigano via, “Again”, ancora, e ogni miglio è un peso in meno sul cuore, fino a quando giungerà quasi il momento in cui si potrà di nuovo urlare ‘Terra!’, e sarà il momento di ritrovarsi (“You will find me again / We will breathe fast […] I just feel pure stars on your skin”) pelle a pelle. In certi viaggi – fortunati, voluti, sognati – l’assenza si fa quasi presenza nella memoria e nell’anima, in ricordo di certi momenti che sono epifanie, albeggiare di pensieri (Breakfast at Sunrise / Hotel room), “eternal presence”, presenze continue e insistenti. Come certi sogni, alcuni amori non spariscono mai dall’orizzonte nonostante le distanze (Love from distance / St. Pauli), e mille domande si infrangono dolci e malinconiche come piccole onde alzate dalle carene (“What do you hope when you hope? / What do you dream when you dream? / How’s your touch when I’m a thougt? / How’s your love when I’m just a feel?”), ad increspare il mare scuro di notte e di pensieri. E proprio quando ti sembra che nulla più sarà uguale a prima, che non toccherai mai più terra o che – se lo farai – sarà una terra diversa da prima a da tutte quelle che hai mai calcato, dolce e amaro giunge l’approdo: alla fine si ormeggia, mollando le ancore (“Turn me around and round and round / and I’ll say stop / Turn me around and round and round / Play for me / Don’t let the sun the sun the sun / Come in / Lay love lay lay lay / Lay love lay”) e tutti i pensieri fatti. Tocca rimanere un po’ dove si è giunti, Around, quantomeno per godersi il ricordo del viaggio.
“Open sta per l’anima che si apre al sentire, trattenere senza contenere, saper lasciar andare; una forma di educazione sentimentale”, mi aveva segnalato Max qualche settimana fa, prima che uscisse questo viaggio che – in fin dei conti – è durato quasi dieci anni. “È tutto in costruzione: usciranno altre cose, un progetto discografico acustico… E molto altro.”
In questo senso, ci saranno altri viaggi e altri percorsi, altre ‘scie’ da ripercorrere, e tante altre storie da vivere per raccontarle. Ma con calma: che vale sempre la pena di viaggiare, se poi hai anche il tempo di ricordare.