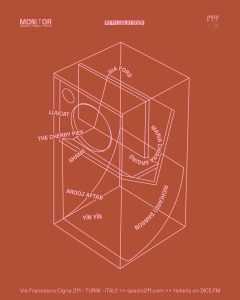Dieci anni, dieci canzoni

Sembra impossibile, eh? Dieci anni. Dieci anni senza. Dieci anni senza LORO!
L’annuncio avveniva proprio nel giorno che inaugurava l’autunno del 2011, e non a caso: nessun gruppo così “estivo” a livello superficiale (ovvero a limitarsi all’ascolto di qualche hit, nemmeno tutte) era in realtà così adatto alla stagione incombente.
Il sapore agrodolce dei loro pezzi lo rivela apertamente, si accompagnano a buon vino e castagne, più che a birra e hot dog dell’immaginario southern rock.
Ma, d’altronde, i “quasi fab” four erano una meravigliosa anomalia di quella zona circondata da una varietà geografica con pochi eguali, partendo dai canyon semi-desertici per arrivare alle paludi che lì iniziano, per proseguire in Florida, passando attraverso parchi naturali e cascate.
Athens, in Georgia, nasce come località universitaria, non ancora città, alla fine del XVIII secolo. Solo dopo una decina d’anni si trasforma in un vero e proprio centro abitato, che oggi conta poco meno di 200.000 abitanti.
L’humus culturale, pertanto, ha favorito uno sviluppo dell’Arte sotto molteplici forme: rimanendo nel campo della Musica, i primi nomi a venire in mente sono quelli dei B-52’s e, appunto, degli R.E.M., anche se non si possono dimenticare decine di artisti contemporanei, come Widespread Panic, Indigo Girls, Pylon (questi ultimi apertamente citati più volte da Stipe & Co. come un’influenza primaria), Matthew Sweet, Love Tractor. Nonché gente che graviterà successivamente intorno alla scena cittadina come Neutral Milk Hotel, Danger Mouse, Vic Chesnutt, Drive-By Truckers, of Montreal, Elf Power, Olivia Tremor Control: chi più, chi meno, tutti debitori nei confronti dei sopra citati.
La storia la conoscono tutti: l’incontro di Peter Buck con Michael Stipe nel negozio di dischi in cui il primo lavorava, il concerto per la festa di compleanno della ragazza di Bill Berry, polistrumentista che all’epoca siedeva dietro la batteria (e di gran lunga il musicista più preparato, seguito da Mike Mills che già era suo amico) e al quale proprio la fanciulla (Kathleen O’Brien, Dio la benedica) avrebbe presentato Buck, suo precedente fidanzato, e quello strano soggetto di Stipe (uno che faceva credere a tutti, consapevolmente o meno, che quella che lo accompagnava sempre fosse la sua fidanzata, mentre si trattava della sorella, amica di Kathleen).
I R.E.M. nascono così, quasi per caso, grazie a un incontro fortuito e a ragazze che facevano vita da college. College che i nostri abbandoneranno presto, convinti dal fratello del titolare della I.R.S. Records (futura casa discografica dei Nostri), per la quale agenzia di spettacoli lavorava proprio Bill, a insistere col battere qualsiasi bettola nell’arco di 100 km da casa.
Quattro individualità ben definite, a creare un amalgama di raro equilibrio: vengono in mente quei quattro che “fab” lo erano davvero, giusto? Ma non scordiamoci dei coevi irlandesi che nello stesso periodo cominciavano, pressoché allo stesso modo, dall’altra parte dell’Atlantico, quegli U2 che rimarranno il loro contraltare europeo sul fronte delle nuove sonorità.
Ma non è tanto per la storia, abbiamo detto, che scriviamo queste righe: la trovate ampiamente raccontata in vari libri, articoli, blog.
Quello che ci domandiamo, a questo punto, è se proprio non avremo più nulla di “remmiano” cui aggrapparci.
Perché, Baseball Project a parte (trattasi di una serie di album dedicati a quello sport, eseguiti da una sorta di supergruppo indie fondato da Steve Wynn e cui hanno partecipato sia Mills che Buck), dagli ex componenti del gruppo pare che non si possano attendere che collaborazioni “esterne” oppure opere di valore inferiore a quanto prevedibile in base al potenziale (quelle di Peter), o quantitativamente poco rilevanti, benché pregevoli, quali quelle di Michael Stipe (tre singoli in poco più di un anno).
È vero che il lascito del gruppo è consistente ed appartiene, nella quasi totalità, a quelle rarità trascendenti la temporalità e composte da un corpus riascoltabile senza annoiare. Ma è altrettanto vero che non se ne avrebbe mai abbastanza, di quel college rock per ogni età, e dieci anni senza un’uscita che abbia impresso quel marchio sonoro sono oggettivamente un lasso di tempo ormai troppo lungo, per chiunque li ami.
Consoliamoci riascoltando qualcosa, memori del fatto che nessuna playlist o antologia renderebbe giustizia a un gruppo i cui album, perlomeno la maggior parte di essi, vanno ascoltati interamente perché “Volevamo fare dischi come ‘Aftermath’ degli Stones, senza riempitivi” e ci sono riusciti quasi sempre.
Non una lista delle migliori, dunque, e neppure di quelle più significative per delinearne i contorni: solo dieci canzoni, una per ogni anno di assenza dalle scene, senza alcun filo logico.
Radio Free Europe
Impossibile non partire da qui: sia nella versione a 45 giri (reperibile su “Eponymous“, antologia del 1989 contenente anche un inedito), sia in quella più conosciuta che compare su “Murmur“, questa canzone rimane un insospettabile istant classic, secondo una tradizione di successi che i nostri continueranno a sciorinare adottando canoni apparentemente lontani da ogni regola pop. Ritmica new wave, chitarra alla Byrds, atmosfera velvettiana (l’influenza più marcata, almeno agli inizi, è quella esercitata dai Velvet Underground, ma più quelli dal terzo album in poi, rispetto ai primi due, universalmente riconosciuti i loro capolavori). E quelle liriche nonsense, figlie di immagini sconnesse partorite dalla mente di Stipe e del cut-up, la tecnica attraverso la quale si tagliano parti di un testo per poi ricomporlo casualmente, il che non conferisce alcun contenuto ai testi, come ripeterà spesso lo stesso Michael. Ma non sarà sempre così.
Losing My Religion
E se era inevitabile partire dalla prima in termini temporali, che dire della prima in assoluto, nel senso più totale dell’espressione? Esisterà, nel mondo, qualcuno che non l’abbia mai sentita e, di conseguenza, canticchiata? Se non fosse roba di troppo tempo fa, si potrebbe pensare a uno di quei giapponesi che, credendosi ancora in guerra, ogni tanto venivano scovati nella giungla fino agli anni 80. E sarebbe davvero calzante, perché la perdita di cui tratta uno dei pochi testi compiuti (a contraddire quanto appena asserito nel caso precedente) è quella della ragione, come più volte ribadito da Stipe. Il quale ha anche dichiarato quanto si fossero stupiti di come fosse stata recepita una canzone priva di ritornello, basata su una frase ripetuta di mandolino (certamente non lo strumento più “cool” nel 1991, perlomeno fino a quel momento). Successo planetario e tuttora irresistibile: di quante altre si può dire lo stesso?
(Don’t Go Back To) Rockville
Perché questo articolo è anche un po’ figlio di una storia bella, una storia importante che rappresenta una buona fetta di vita per me e coloro che divennero i miei migliori amici, coi quali abbiamo iniziato questo rito che si compiva ogni venerdì, quando attendevamo l’ascolto delle novità discografiche in quella piccola meraviglia di negozio torinese che portava il nome di questa canzone. E non fatemi aggiungere altro, che tra un po’ piango. Balliamola tutta. Rockville sempre nel cuore.
Begin The Begin
Per molto, molto tempo questa è stata (ma forse lo è ancora, pensandoci bene) la mia opening track preferita. “Lifes Rich Pageant” rimarrà sempre il mio R.E.M. preferito (assieme a “Green“, nel caso ve lo chiedeste), e credo che in parte derivi proprio da come inizia, prima di uno sviluppo clamoroso che ancora mi tiene ancorato all’ascolto ogni volta che lo faccio partire. L’arpeggio e le pennate, il cantato aggressivo, la durezza del ritmo, il basso pulsante. E il primo testo in cui ci si capiva qualcosa. E non era l’unica, su quel disco, ad essere importante e “politica”: anzi, c’era ben di più, in quel senso. Ma non fraintendete, prego: parliamo di coscienza sociale, qui, non di partiti e quisquilie simili.
Popsong 89
Per rimanere in tema di brani d’apertura memorabili, questa è emblematica: appiccicosa senza sembrarlo, chitarra e organo sugli scudi, una ripetizione ossessiva di un testo banalissimo, ma di quella banalità tipica della vita, tant’è vero che descrive una situazione nella quale chiunque si sarà trovato: ti incontro, ti parlo, ma alla fine mi chiedo: “E chi cazzo eri già? Boh!”
A perfect pop song. E si balla esclusivamente con il sinuoso andi dello Stipe più sfacciato.
Can’t Get There From Here
Una mescolanza di stili che non si direbbe possibile: un ritmo disco-funk sul quale si innestano le coloriture folk evocate dall’utilizzo di un produttore del calibro di Joe Boyd. L’esempio perfetto di tutto ciò che sta dentro un disco meraviglioso come “Fables Of The Reconstruction“, volutamente incoerente e irrisolto sin dal titolo, che vale anche coi termini scambiati. Questa non poteva certo stare altrove.
Drive
Anche in questo caso c’è dietro una piccola storia.
Qualche mese fa, improvvisamente, un amico di lunga (ma davvero lunga) data mi manda un messaggio: il video di Drive e la sua dichiarazione di amore totale per questa canzone, scoperta all’improvviso lasciando scorrere le scelte di YouTube.
Roberto, questo il suo nome, è innamorato del Prog, ama svisceratamente i Pink Floyd e in questo brano di apertura di “Automatic for The People” ritrova un’eco delle loro sonorità. Da allora, colto da ardore passionale, me l’ha già re inviata alcune volte, chiedendosi come possa essere così magica l’atmosfera che si sviluppa nelle ballate dei georgiani “prive di veri refrain, ma ammalianti“, per usare parole sue. Ora è quasi un fan della band che un tempo gli era indifferente.
Let Me In
Questa la inserisco in questa lista-non-lista perché è quel tributo che sappiamo: Kurt Cobain si è sparato una fucilata in bocca, non ha retto alla depressione, non ha chiesto esplicitamente aiuto e, a quanto pare, non ha permesso ai suoi amici di entrare nel suo mondo, nella sua nevrosi. Non rimane altro da fare che prendere la sua chitarra da mancino, girarla al contrario e aggredirla per sostenere quel testo disperato.
How The West Was Won And Where It Got Us
Gli anni 80 mi avevano lasciato in eredità un’altra band di consistenza assoluta. Los Lobos erano un esempio di musica totale, svincolata dai generi pur contenendoli tutti, spesso all’interno di una sola canzone. Questo brano di apertura di “New Adventures In Hi-Fi” mi aveva subito evocato Kiko And The Lavender Moon dei losangeleni del barrio, di qualche anno precedente.
Non è poi così diretta, la linea che le porrebbe in relazione: là un’atmosfera quasi inquietante, qui una riflessività contemplativa quasi estatica, ma dinamica, come lo scorrere delle immagini dal finestrino di un’auto o un treno. D’altronde, apriva un album concepito in viaggio, registrando ovunque, come era stato alla base di “Running On Empty” di Jackson Browne o “Rattle And Hum” degli U2.
Ma si sa: la Musica evoca sensazioni le più disparate a seconda di chi ne venga colpito. Un altro brano di rara efficacia, un altro gioiello incastonato in un monile preziosissimo.
These Days
Ancora da “Lifes Rich Pageant“, ma non potevo farne a meno: Questi Giorni sono quelli in cui vorremmo ancora essere cullati da nuove melodie cesellate dai quattro (poi tre, come sappiamo).
Sono i giorni in cui ci mancano terribilmente i nostri amici.
Sono i giorni d’autunno in cui riprendiamo in mano questi album e ringraziamo che ci abbiano lasciato almeno questa testimonianza. E di aver incrociato la loro strada mentre salivano in cima al mondo.